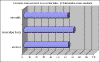La tradizionale 'didattica alla salute' e i progetti per la prevenzione.
Esame dei parametri utilizzati dalle scuole.
Con la più recente
elaborazione condotta lungo l’asse sicurezza e salute, si è ormai fatta
strada l’idea che non ci può essere una completa offerta didattica e una
conseguente matura preparazione culturale senza affrontare in modo
trasversale alle varie discipline il tema della sicurezza sul lavoro.
Purtroppo bisogna però registrare che nella maggioranza delle scuole, dove
pure non mancano i docenti che si candidano a definirsi e a farsi definire
“referenti alla salute”, la ripetitività di pseudo progetti circola
indisturbata tra la noia degli studenti.
Non è difficile immaginare come la qualità di una scuola sia direttamente
dipendente proprio dal piano didattico che quella scuola sa offrire ed è per
questo che le autorità europee hanno progettato di elaborare un piano per
far entrare nelle scuole la sensibilità per la sicurezza. I benefici sociali
sono enormi, se si considera che l’abbattimento degli incidenti sul lavoro
dipende proprio dalla cultura della sicurezza di cui saranno dotati i futuri
cittadini che oggi crescono tra i banchi di scuola.
Il recente convegno romano delle delegazioni degli stati dell’unione europea
(di cui in questo foglio si dà conto) è ormai il punto fermo da cui
partire per diffondere la cultura della sicurezza: in gioco ci sono:
— l’abbassamento del numero (ormai insopportabile) di incidenti sul lavoro;
— e l’innalzamento della qualità (ormai misurabile) delle scuole.
La diffusione di questo nuovo fronte didattico, trasversale a tutte le
discipline, rischia però di essere paurosamente lenta se non vengono
chiamati in causa proprio i parametri e gli indicatori con cui si inducono
le scuole ad autovalutarsi.
Abbiamo perciò voluto visitare lo strumento, ancora sperimentale, che però
con molto successo sta spingendo le scuole a prendere coscienza del proprio
stato e delle proprie potenzialità: lo strumento che nel Progetto Pilota 2
indaga il sistema scuola.
Dobbiamo constatare che i risultati dell’indagine, contenuti in 102 pagine,
si soffermano, a pagina 31 sul “ Contesto esterno”, intendendo per indagine
sul contesto esterno alle scuole quello che attiene alla rilevazione dei
fabbisogni formativi dell’utenza, alla partecipazione reti di scuole e,
infine, alle attività di collaborazione (con altre Istituzioni scolastiche e
con altri soggetti esterni). “L’analisi del contesto è stata finalizzata
alla verifica della definizione, progettazione e programmazione dei progetti
educativi, dichiarati dalle scuole e integrativi dei percorsi didattici, in
funzione della valorizzazione delle risorse presenti nel territorio.
Le scuole rispondenti hanno dichiarato di effettuare rilevazioni del
fabbisogno formativo della propria utenza, come indicato nella Tabella 28,
soprattutto attraverso colloqui (74%), con rapporti instaurati con le scuole
di provenienza (63% circa) e con indagini sulle famiglie (60%).
Nel Grafico 23 di tale documento si prende in esame il numero di accordi
raggiunti per poter potenziare il proprio potenziale formativo da parte
delle scuole ed è utile riportarlo:
Università e Istituti Superiori
agenzie di formazione
aziende private
altre scuole
Associazioni di genitori
parti sociali
Istituti finanziari
associazioni di categoria
esperti esterni
Enti Locali
ASL (per l’handicap)
sanità
altro.
Come si vede sono presenti i bisogni di rapportarsi ai contenuti sanitari,
ma è molto utile osservare direttamente il grafico, dal quale emerge come
tali contenuti siano relegati agli ultimi posti:
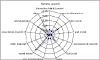
Grafico 23
Se poi si volesse conoscere il contenuto delle problematiche sociosanitarie
che le scuole hanno dichiarato di seguire con maggiore attenzione, bisogna
rifarsi al Grafico 38 e si scopre che rimangono tradizionalmente legate alla
tossicodipendenza, all’alcolismo e alla criminalità, senza accenno alla
“sicurezza”, che pure avrebbe tutta la possibilità per meglio inquadrare
proprio queste tre grandi e problematiche famiglie di “insicurezza” sociale: